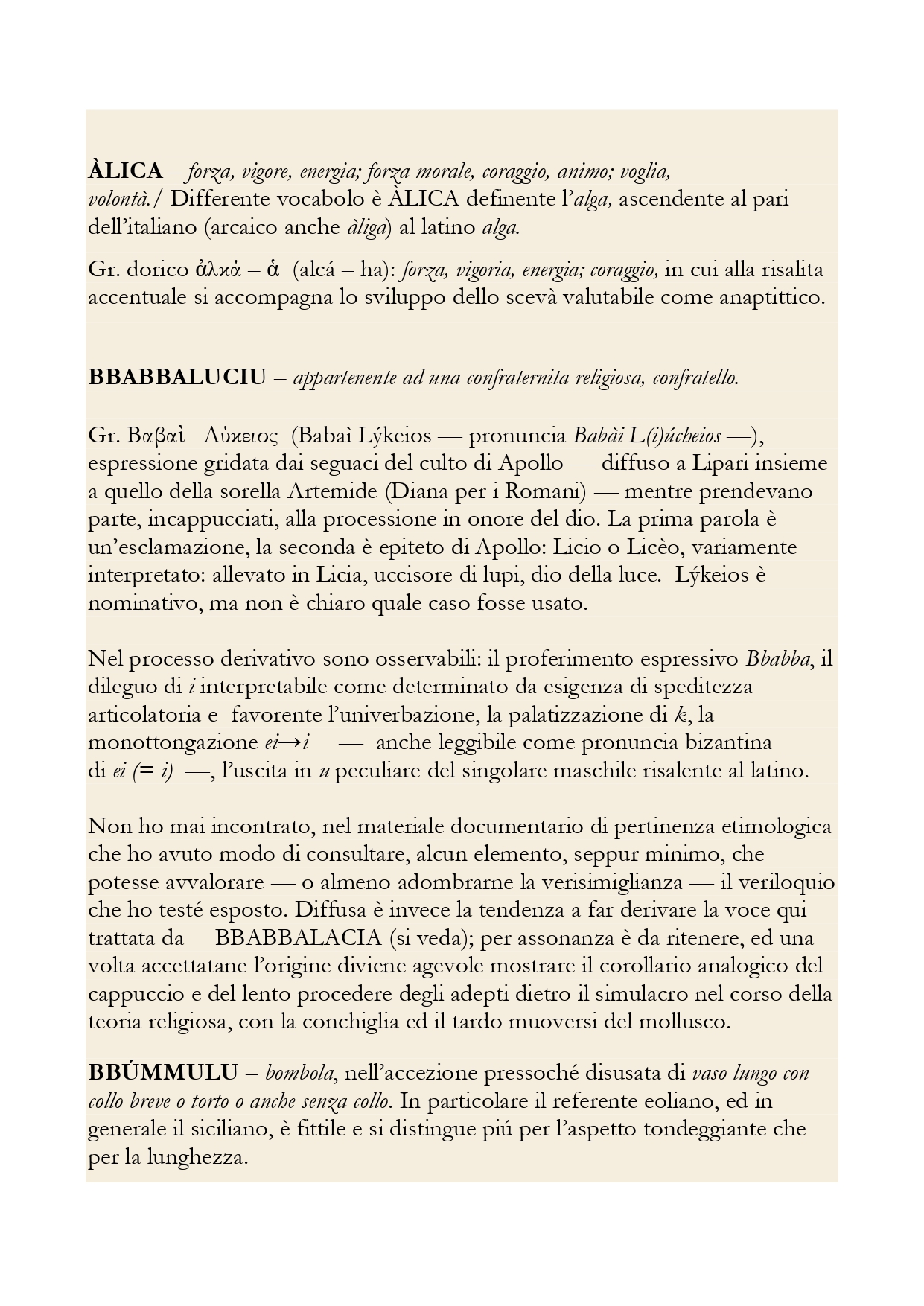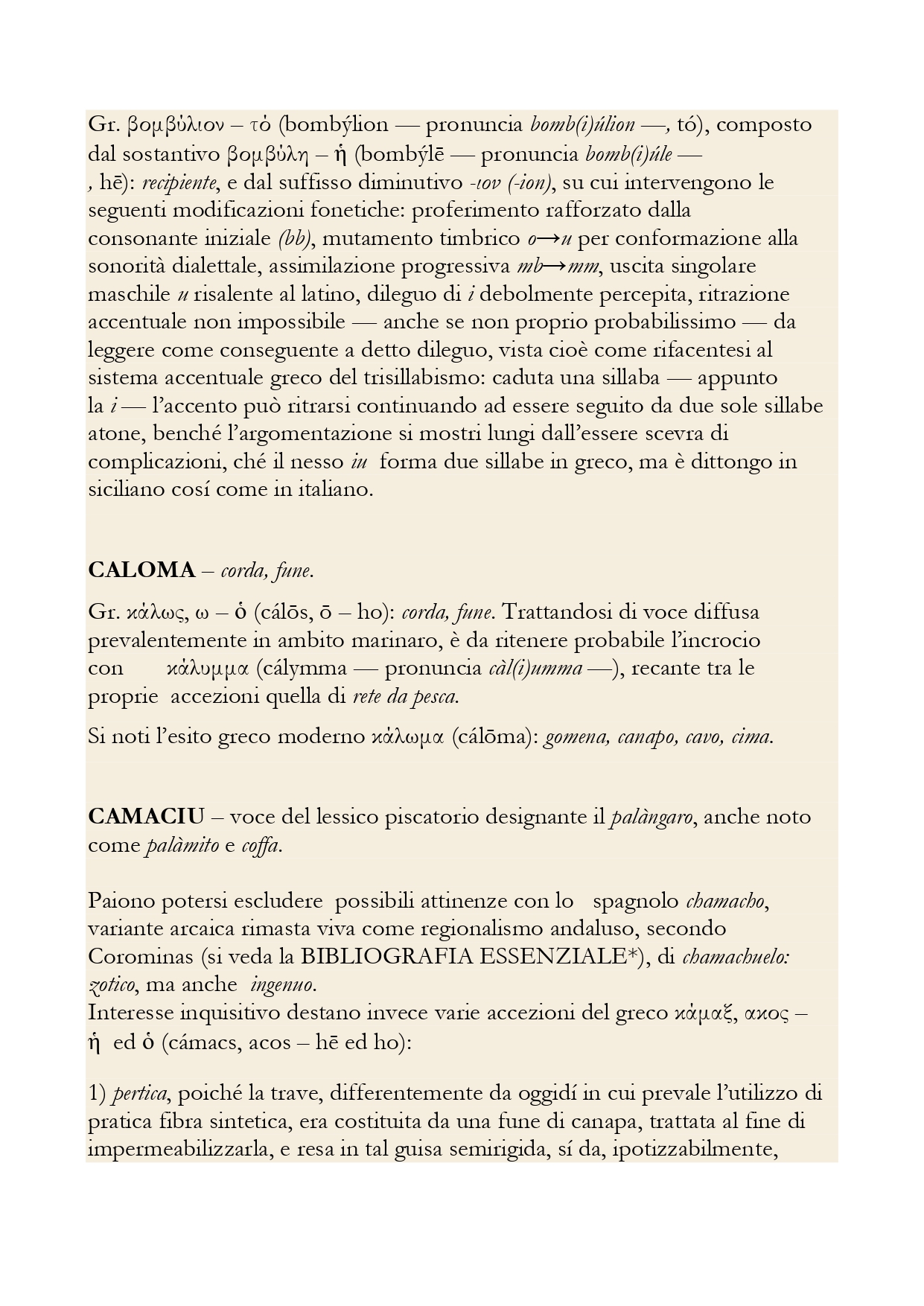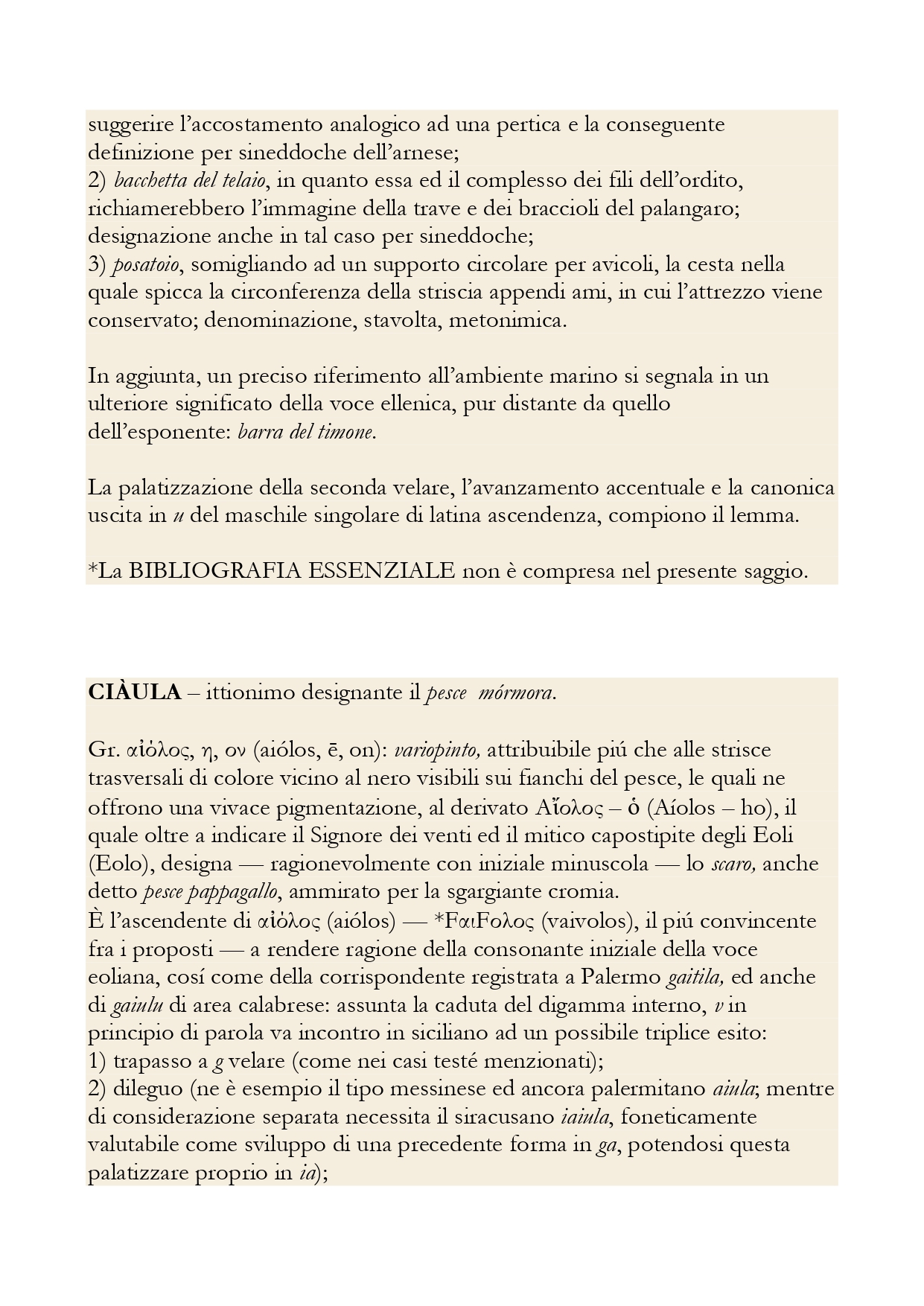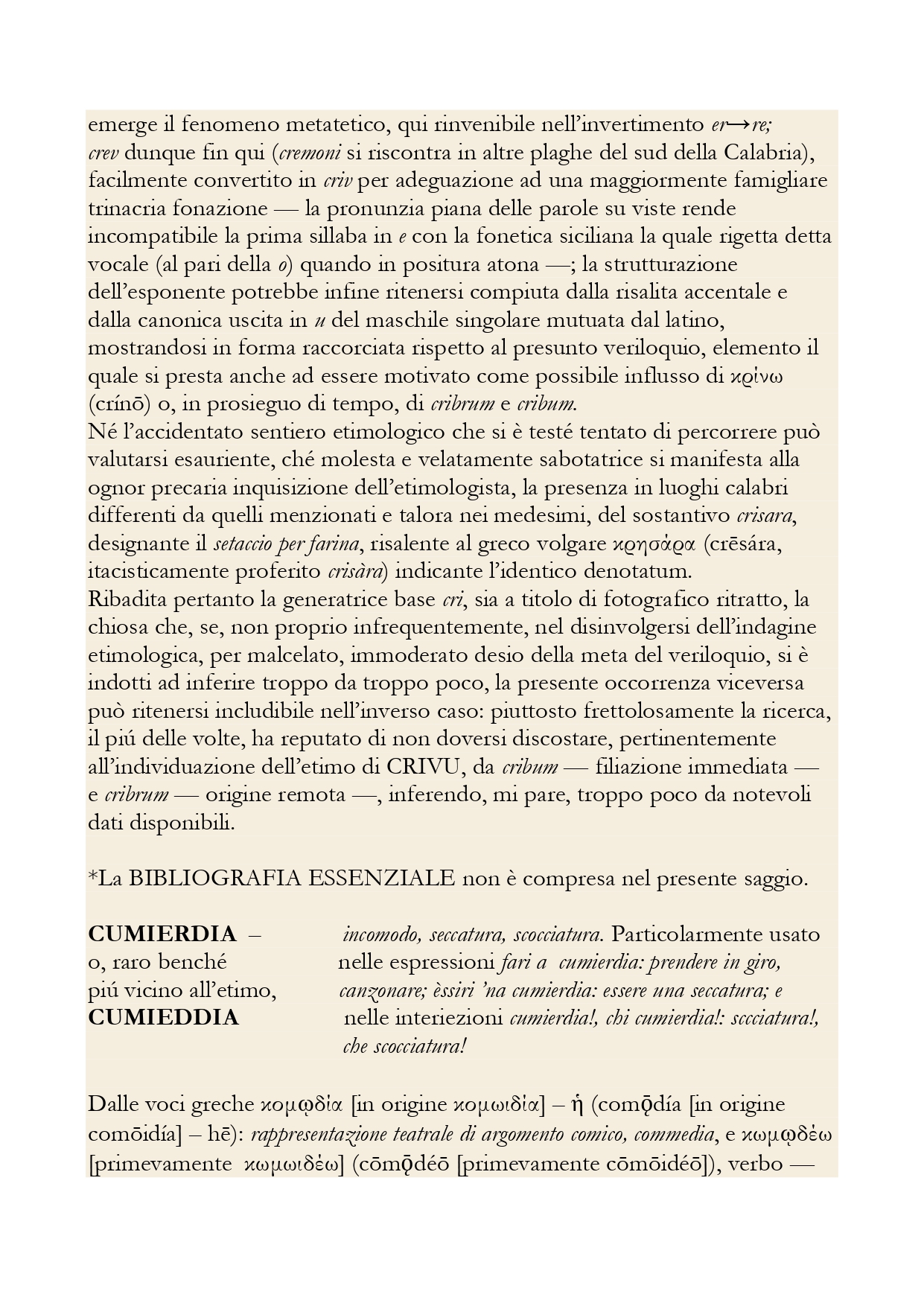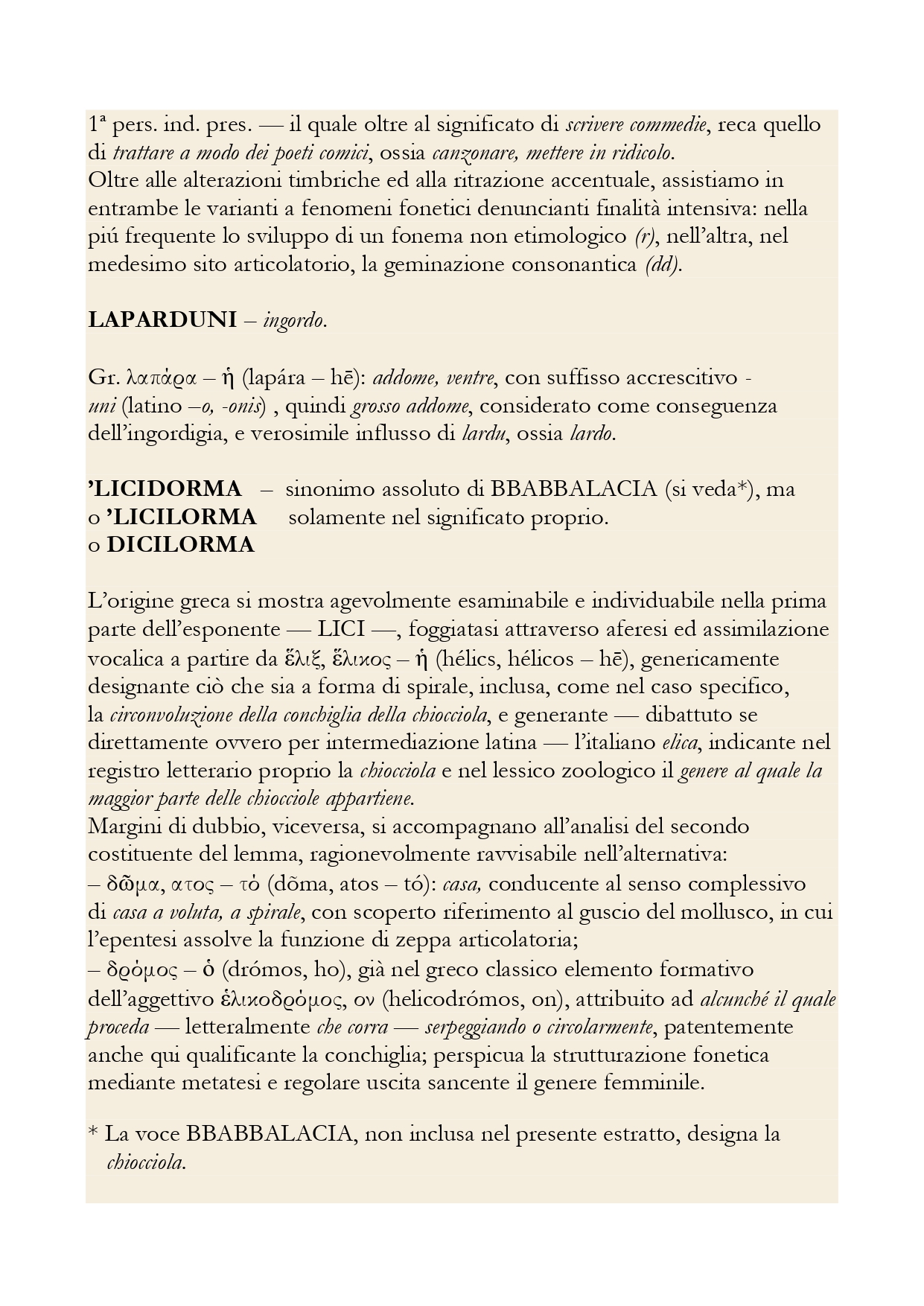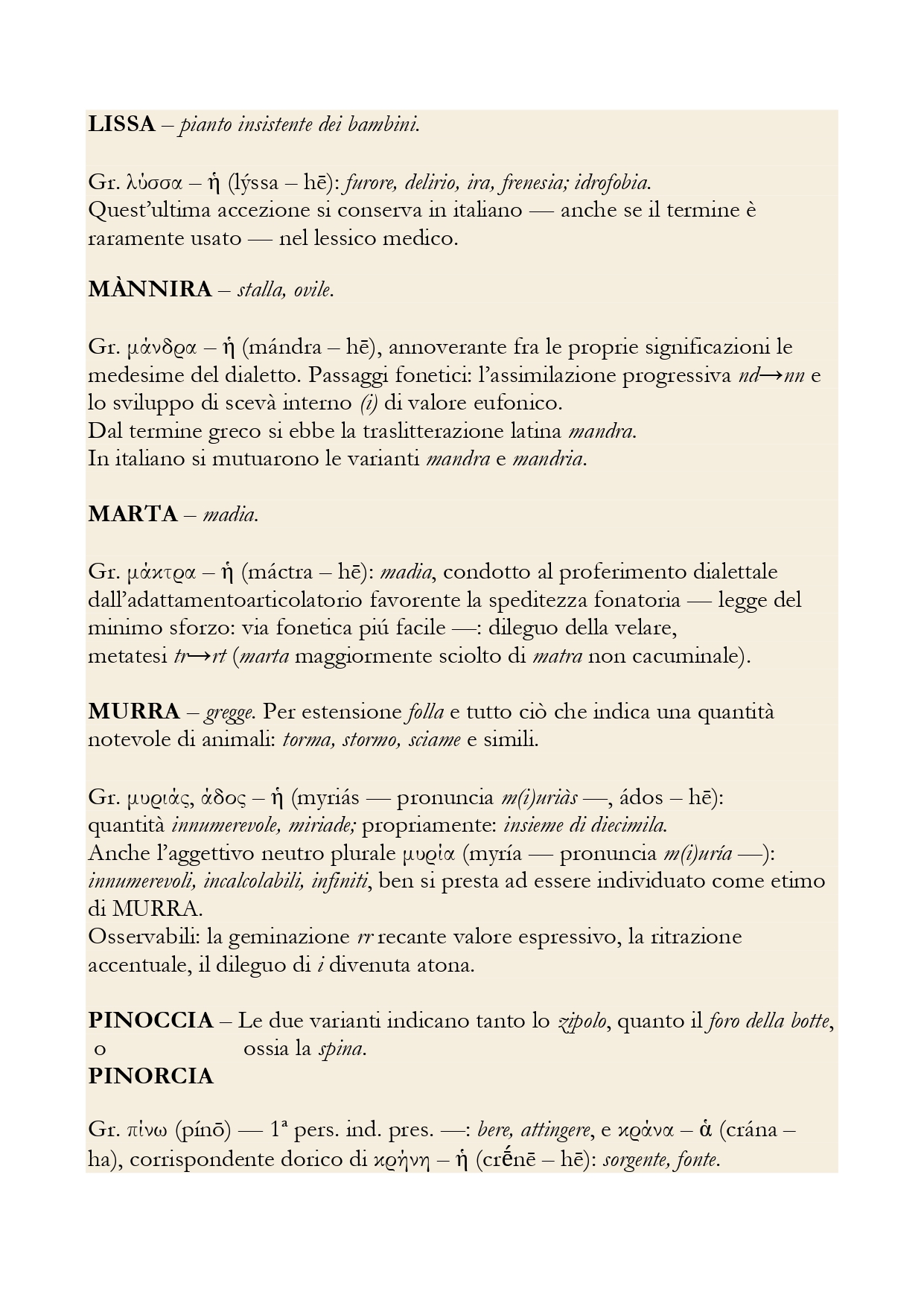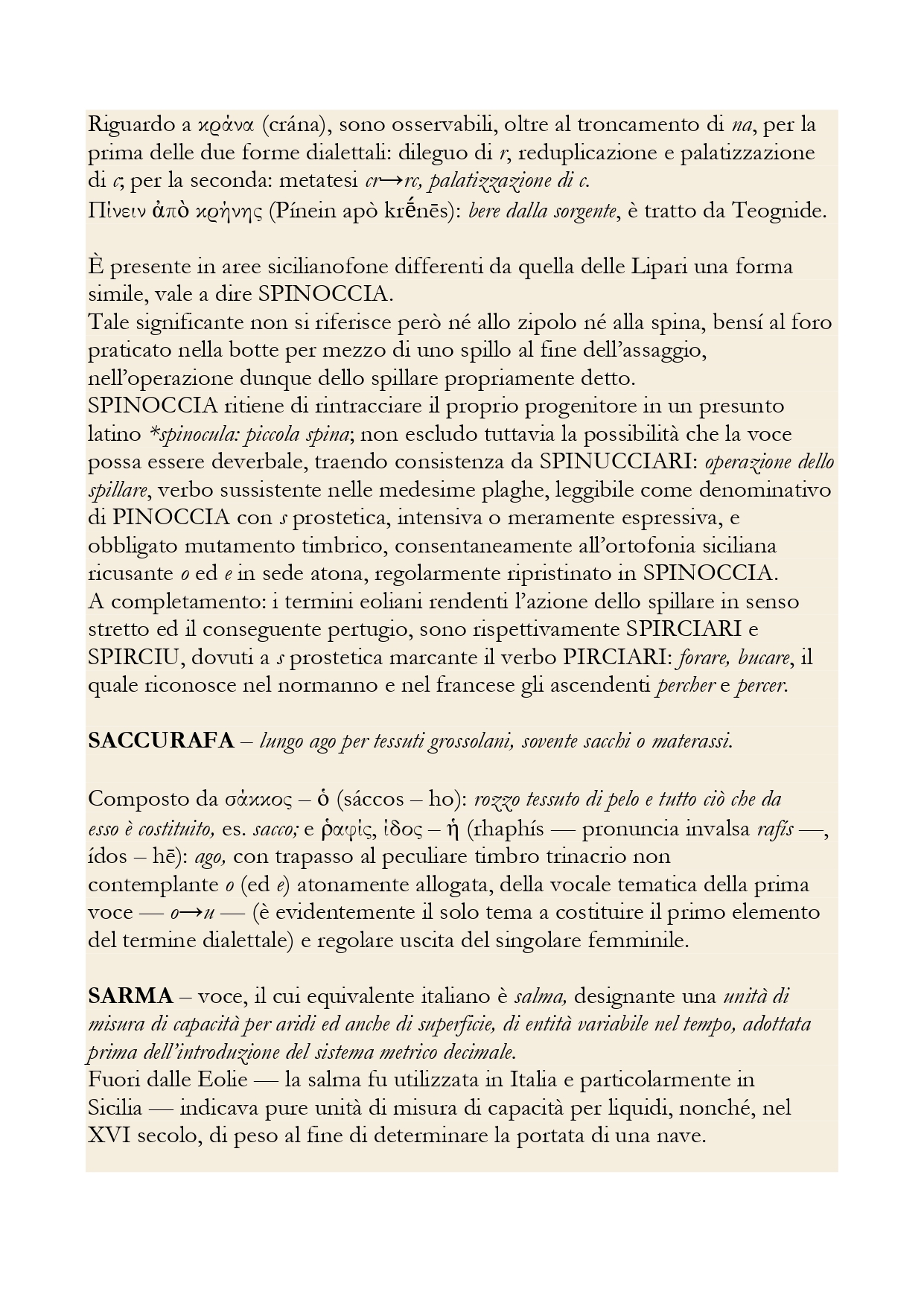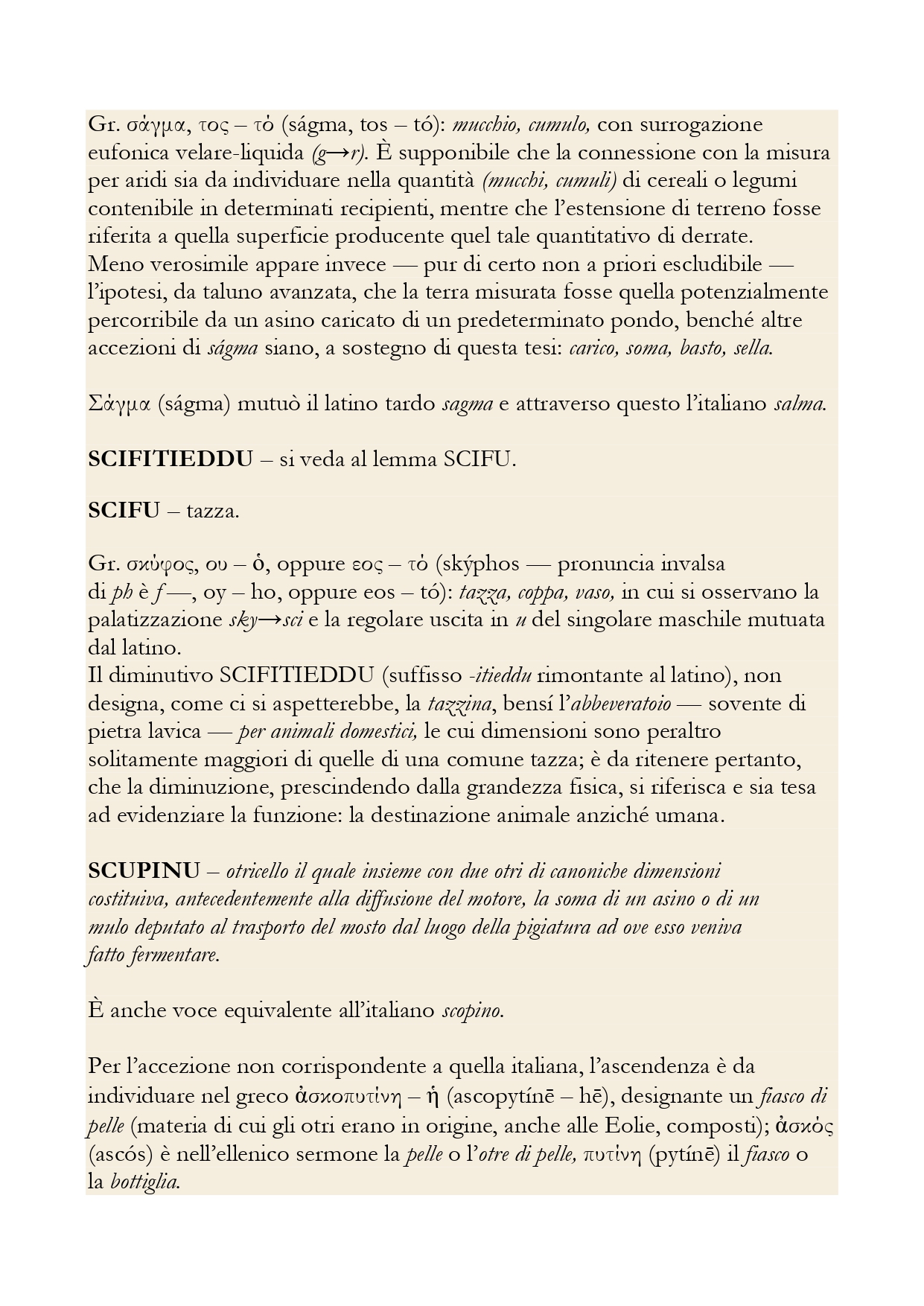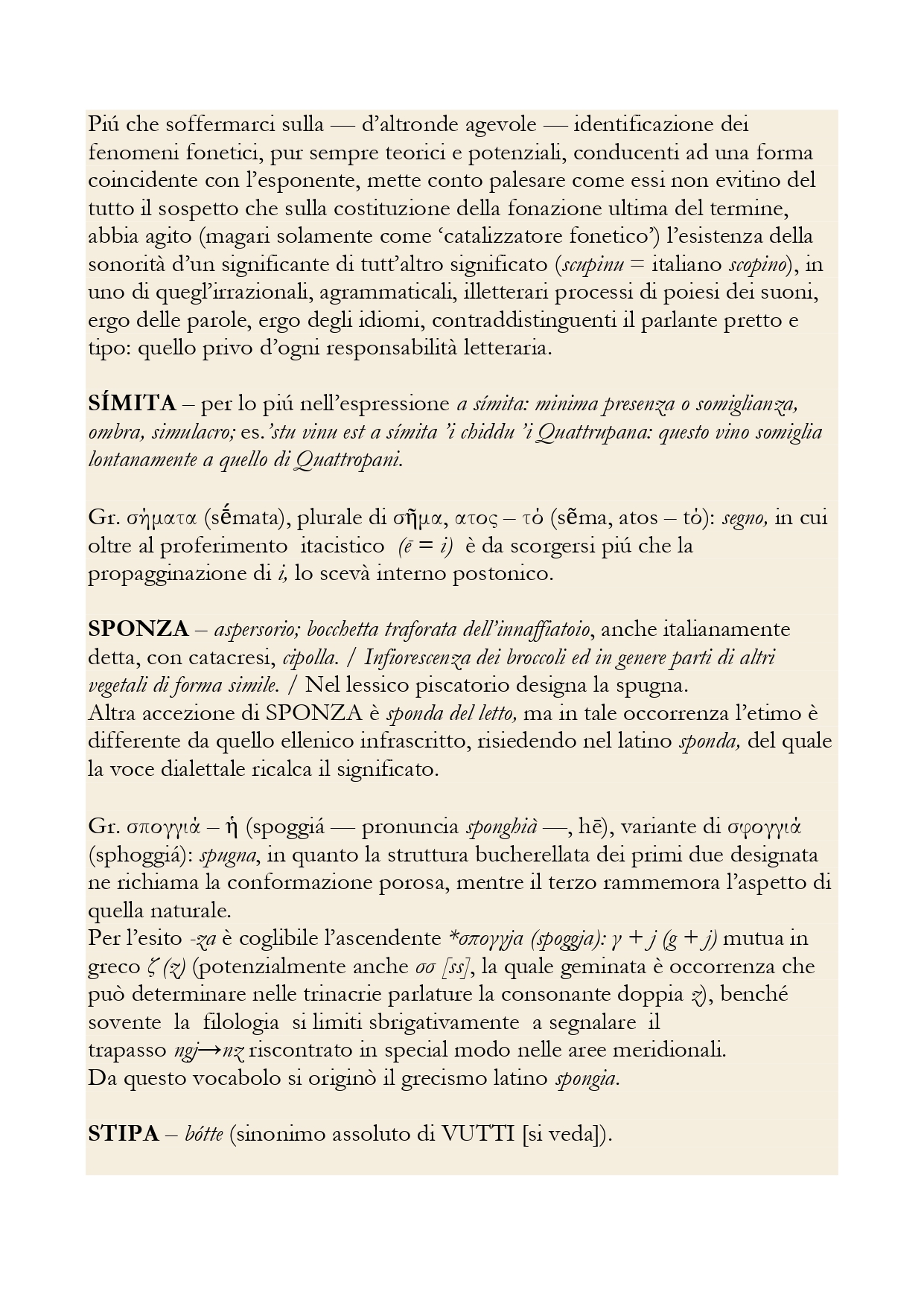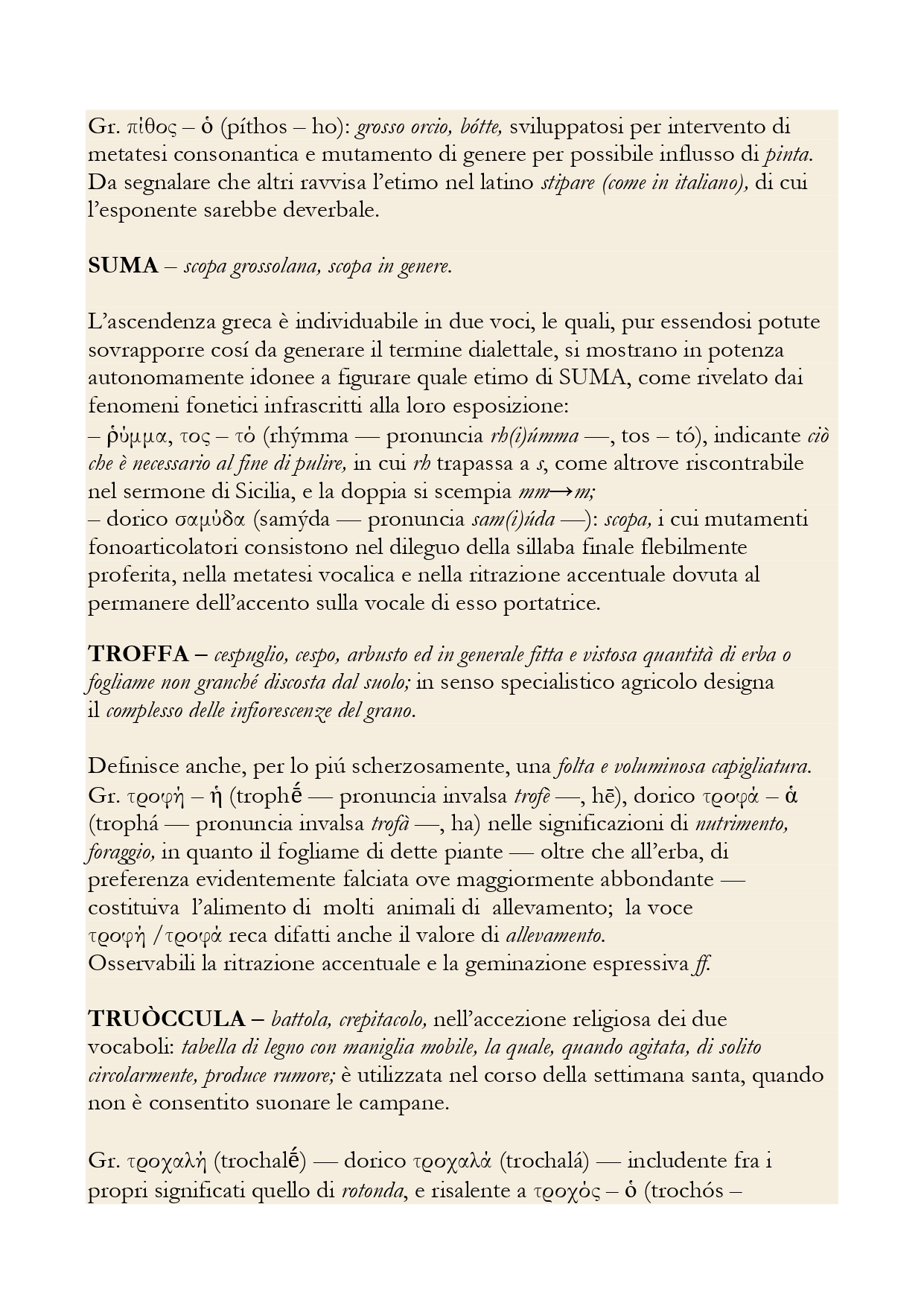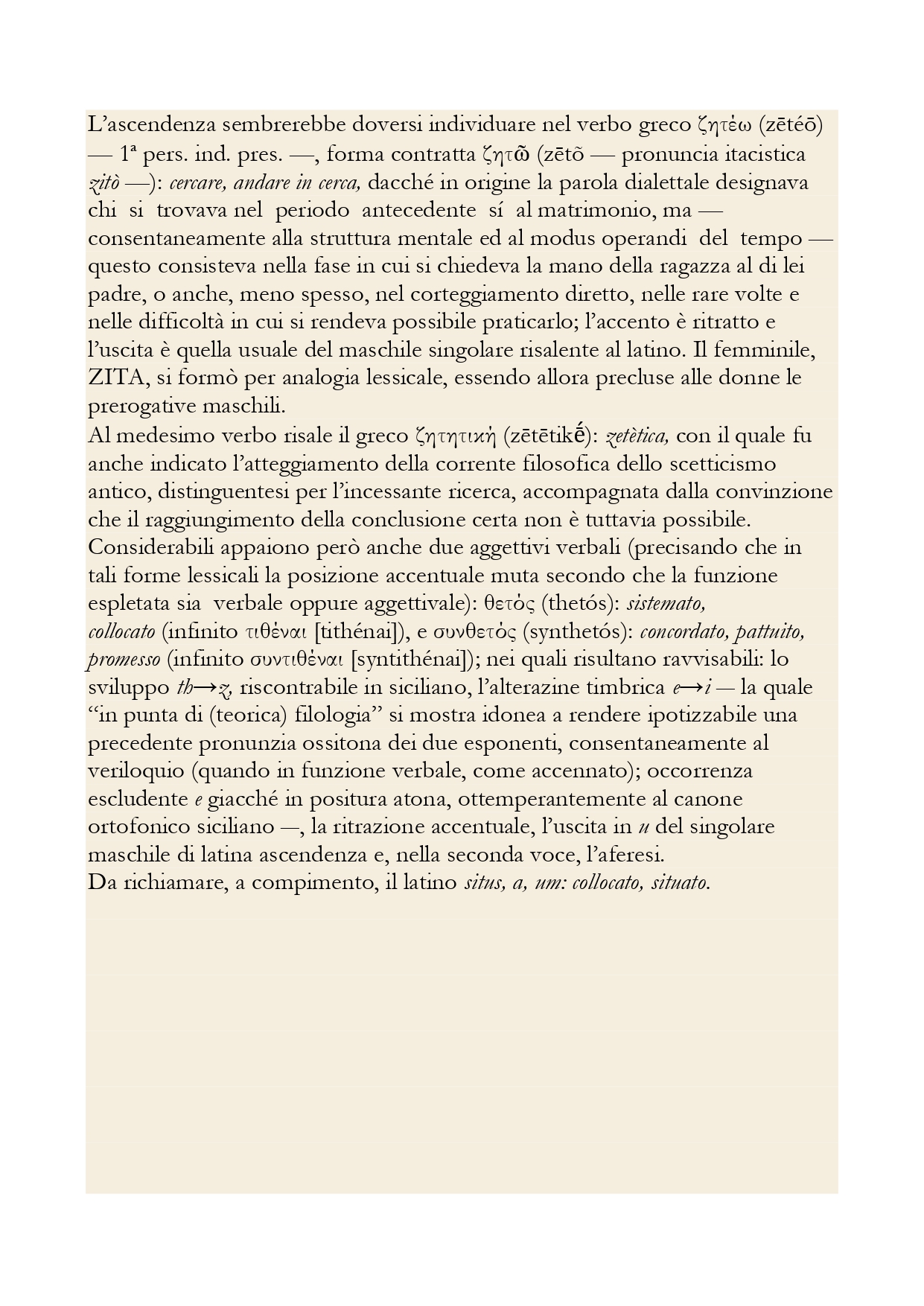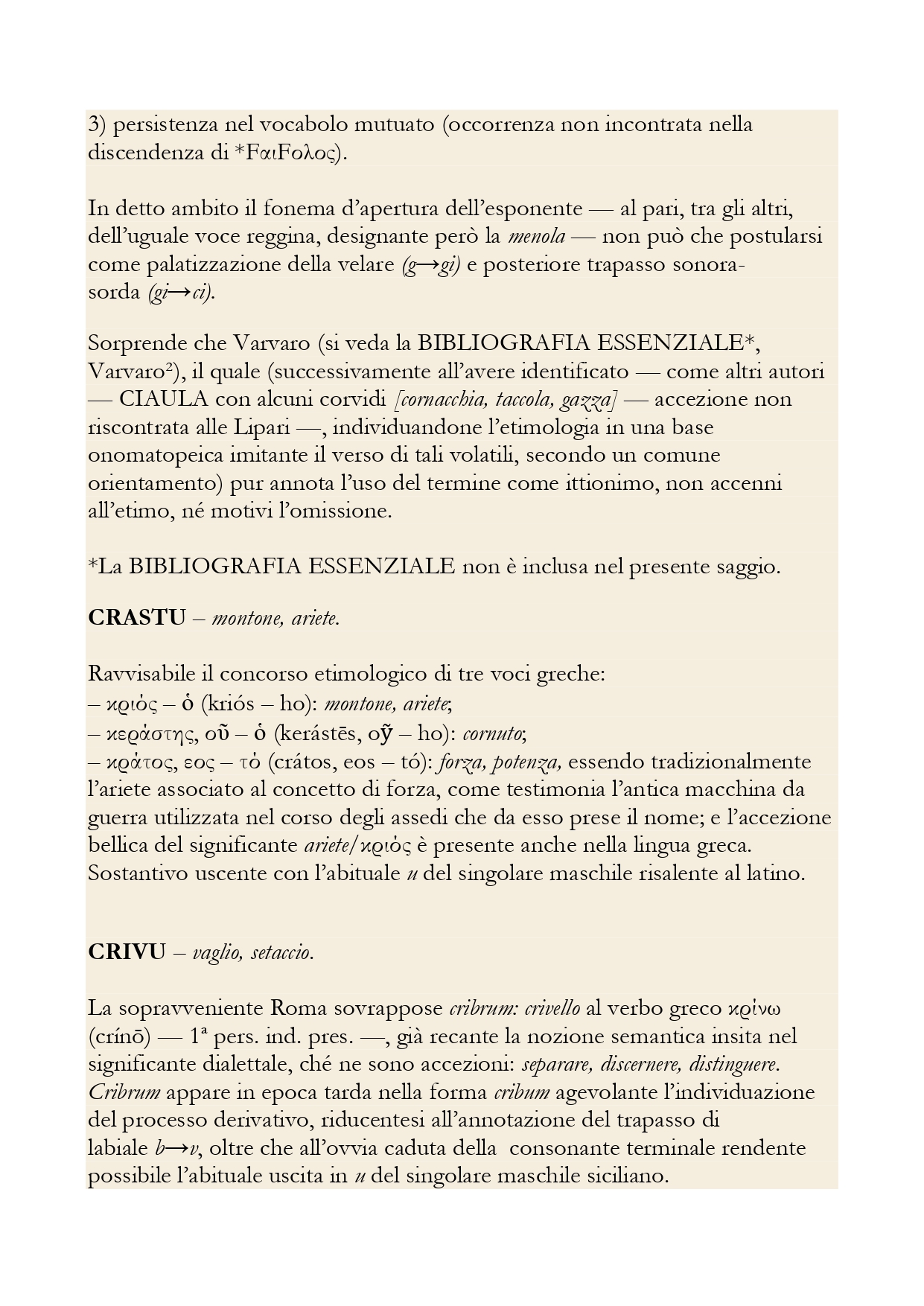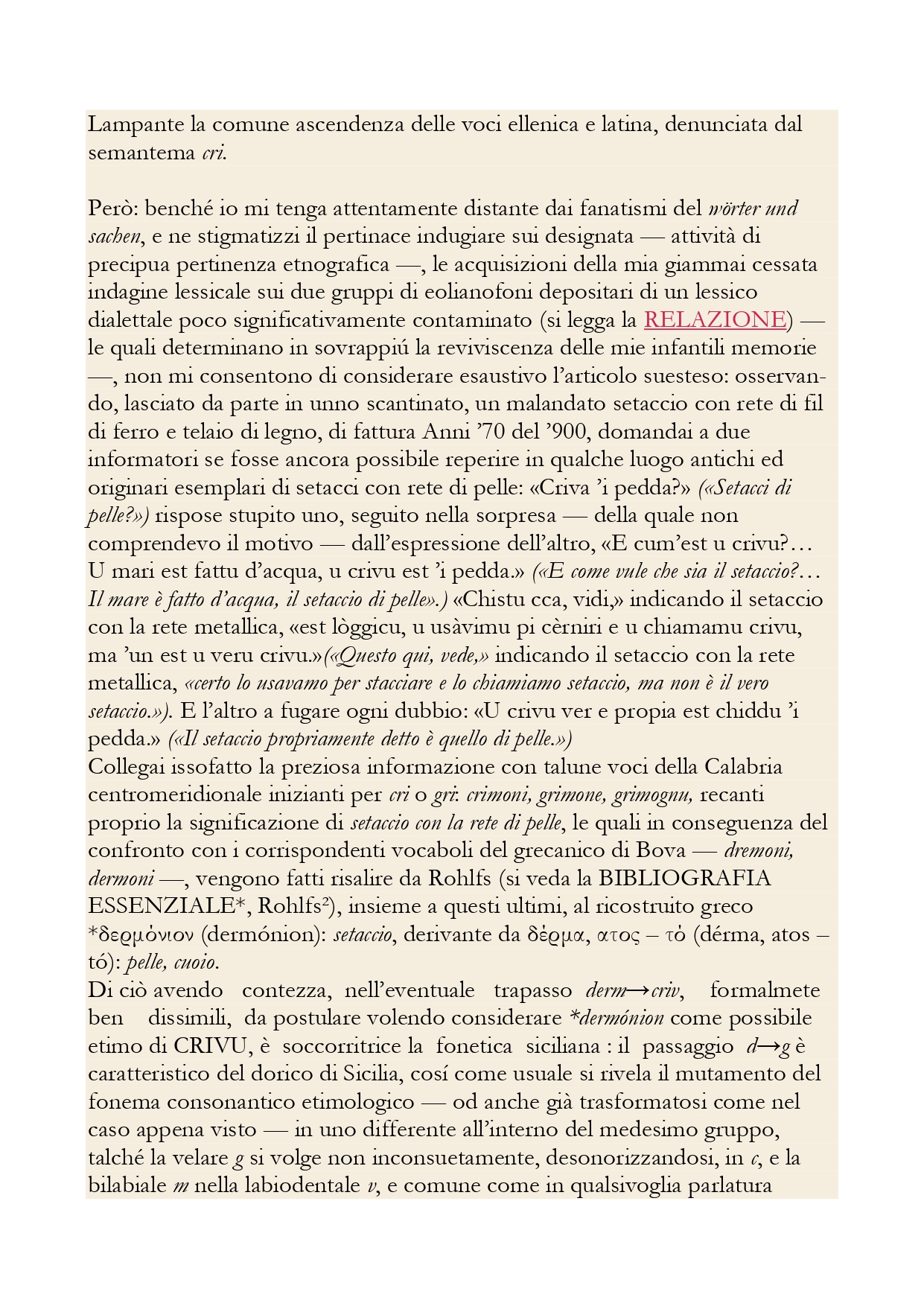Di seguito un estratto minimo di 30 voci dialettali eoliane di ascendenza greca, selezionate fra gli oltre 700 lemmi della seconda edizione de ‘LA NOBILTÀ DELLA LINGUA GRECA NEL DIALETTO EOLIANO’.
NOTE
1) Nella traslitterazione delle voci greche:
– l’accento, quando ne sia portatore un dittongo, è stato conservato sulla seconda vocale, come è d’uso nella lingua d’origine; il lettore consideri tuttavia che ai fini della pronuncia esso è da intendersi sulla prima vocale (ad esempio: κείρω, traslitterato keírō, va proferito kéiro).
– Il κ, reso con c innanzi a vocale aspra, è espresso con k prima di vocale dolce (di fatto solamente i ) sí da non alterarne il suono il quale è in greco sempre velare.
2) Nella trattazione dei lemmi, con il termine attenuazione si intende il trapasso da occlusiva sonora oppure aspirata ad occlusiva tenue (esempio: d→t).
3) Le volte in cui negli articoli non viene specificato che la pronuncia di υ/γ è (i)u, si intende assunto il proferimento bizantino (=i), ché coincidente con il corrispondente fonema dell’esponente, oppure l’indicazione del modo di pronunciare risulta irrilevante, riscontrandosi nell’esponente un dissomigliante esito timbrico.
4) È peculiarità dell’idioma di Sicilia innestare le uscite di provenienza latina sulla radice, sul tema o piú in generale sulla prima parte della parola, comunque sia formata e quale che sia la lingua da cui derivi.
Riguardo a ciò è opportuno precisare in particolare quanto segue, intorno alle desinenze infinitivali ari, íri ed iri (atona) che è possibile riscontrare nel dialetto siciliano e che ne costituiscono le tre coniugazioni possedute; ed alla desinenza nominale u dei maschili singolari:
– inerentemente alle prime, le uscite del modo infinito latino āre, ēre, ĕre, īre (diatesi attiva), ed āri, ēri, īri (diatesi passiva), alle quali i suffissi infinitivali dialettali testé visti ascendono, sono propriamente terminazioni, in quanto re e ri costituiscono le desinenze effettive, mentre la vocale la quale le precede appartiene al tema (tranne la ĕ di ĕre, la quale è mera vocale di unione tra il tema e la desinenza); caso concreto: admurmurare — ossia bisbigliare —, ove admurmura è il tema e re la desinenza.
– Quanto alla u desinenziale, essa è rinvenibile nella seconda e nella quarta declinazione latine, ove non è però desinenza, bensí appartenente al tema; esemplificativamente: pontus: mare, nominativo singolare 2ª decl., in cui pontu è tema ed s desinenza; laurus: alloro, nominativo singolare 4ª decl., lauru tema, s desinenza.
Non risulta disutile inoltre soggiungere, a titolo di supplemento espositivo, che il tema prisco della seconda declinazione latina esce in o, conformemente all’indeuropeo, al pari della 2ª decl. greca, la quale lo ha invece conservato nelle fasi avanzate della lingua.
5) Attinentemente alle mutazioni o adattamenti timbrici alle tipicità sonore del siciliano, nei lemmi richiamato, ai fini di un inquadramento tecnicamente preciso e complessivo del vocalismo tonico ― caratterizzante nella classificazione degli idiomi ― dei dialetti siciliani, riporto di seguito com’esso si sviluppò dal latino, raffrontandolo con il corrispondente italiano e completando l’esposizione elencando le vocali e i dittonghi greci la cui pronuncia risultò variata in epoca bizantina, nella quale il suono di i fu prevalente.
Concomitantemente mostrasi precipua nel vocalismo atono, la ricusazione di e e di o in sede scema di accento.

6) Il termine fonetica (insieme con fonetico, di cui è retroformazione, e foneticamente) è usato nell’accezione tradizionale e generale di studio dei suoni del linguaggio, non secondo l’orientamento della linguistica contemporanea la quale lo contrappone a fonologia (benché tradizionalmente di fonetica fosse sinonimo) o fonematica o fonemica.
7) Salvo occasionali occorrenze, rimane fuori dagli obiettivi del glossario la resa fonetico-mimetica delle voci dialettali, anche poiché non necessariamente coincidente fra i differenti siti di un territorio articolantesi in sette isole.
Parimenti i segni grafici i quali raffigurano definizioni tecniche quali ‘velare’, ‘palatale’…, vanno evidentemente riferiti a fonemi, non a foni, i quali ultimi in nutrito quantitativo pure ― ma non certo esclusivamente ― per il contributo di estemporaneità fonatorie del parlante, in prosieguo ‘regolarizzate’ dai reiterati uso ed imitazione, possono comportare il cangiamento del locus articolatorio.
8) Essendo intento precipuo della presente ricerca l’individuazione della presenza linguistica greca nell’idioma eoliano, si è rinunciato ad indicare sistematicamente se le voci dialettali risalgano all’ellenica favella per via diretta o per il tramite di intermediari, in ispecie ove ciò risulti controverso.